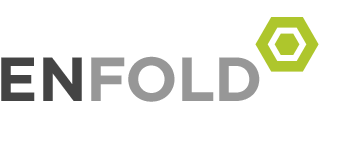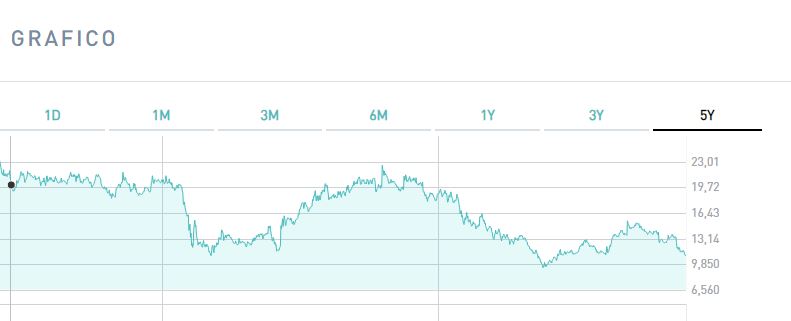Ha chiuso oggi Ecomondo. La 26^ edizione ha registrato un +15% di presenze rispetto al 2022. Alla giornata inaugurale ha partecipato il ministro dell´Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha visitato con il presidente di IEG Maurizio Ermeti, l´AD Corrado Peraboni e la global exhibition director Alessandra Astolfi, l´area espositiva e ha definito Ecomondo «da modello pionieristico a bandiera nazionale». E ancora, hanno partecipato: Francesco Corvaro, inviato speciale per il Cambiamento climatico del Governo italiano alla COP28; il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e l´assessora alla Transizione ecologica del Comune di Rimini Anna Montini.
Nei quattro giorni di manifestazione, sono stati ospiti a Ecomondo il viceministro all´Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava, i sottosegretari al MASE Claudio Barbaro e alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, agli Interni Emanuele Prisco. La visita di componenti della Commissione parlamentare Ecoreati. I presidenti della Regione Campania Vincenzo De Luca e Michele Emiliano della Regione Puglia. I consorzi di filiera e le associazioni di impresa, partner storici della Manifestazione, a partire da CONAI, Utilitalia e Assoambiente, Confindustria, assieme a Commissione europea, OCSE, FAO, UfM, EEA, ISWA, coordinati dal Comitato tecnico scientifico di manifestazione diretto dal professor Fabio Fava dell´Università di Bologna, fanno di Ecomondo il community catalyst di rifermento nell´area euromediterranea con un calendario di oltre 240 eventi.
Oltre 630 gli operatori esteri internazionali ospitati grazie alla collaborazione di Agenzia ICE e Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale con la rete globale di regional advisor di IEG e anche della Regione Emilia-Romagna, in particolare per il settore della Blue Economy, provenienti da Nord Africa e Africa subsahariana, Area balcanica, America Latina, Nord America, India e Medio Oriente, che complessivamente hanno generato 2.700 business matching.
Premio Sviluppo Sostenibile 2023.
Città circolari, mobilità lenta, gestione delle acque: i vincitori del Premio Sviluppo Sostenibile 2023 AMIU Genova, Società Metropolitana Acque di Torino e il Comune di Legnano sono i tre vincitori del Premio Sviluppo Sostenibile 2023, consegnato oggi a Ecomondo, il salone della transizione ecologica di Italian Exhibition Group in corso alla fiera di Rimini fino a venerdì 10 novembre. Il premio, istituito per il tredicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-Italian Exhibition Group con il patrocinio del MASE, è destinato a imprese, start-up e Amministrazioni locali che si siano distinte per eco-innovazione, efficacia dei risultati ambientali ed economici e del loro potenziale di diffusione. Per la categoria economia circolare, è stata premiata AMIU Genova spa in collaborazione con il Comune di Genova; per mobilità sostenibile, il Comune di Legnano; per la gestione circolare delle acque, la Società Metropolitana Acque di Torino . SMAT spa. Da un progetto per realizzare una ´città circolare´ a interventi per una mobilità lenta a una migliore qualità degli spazi urbani periferici, i tre vincitori perseguono un unico obiettivo: mettere in atto azioni di economia circolare per il benessere dei cittadini.
L’edizione 2024 di Ecomondo si svolgerà dal 5 all’8 novembre.